Continuano gli incontri in presenza del Gruppo Parole in Giardino: distanziati ma vicini per parlare di libri, emozioni, parole, immagini, condividendo riflessioni e pensieri.

Incipit del romanzo” Quel che affidiamo al vento”
Ne aveva sentito parlare la prima volta alla radio. Un ascoltatore era intervenuto a fine programma per raccontare cosa lo facesse stare meglio dopo la scomparsa della moglie. Ne avevano discusso ampiamente in redazione prima di fissare il tema della puntata. Tutti sapevano di lei, che dentro aveva l’abisso. Ma Yui aveva insistito, che qualunque cosa sarebbe venuta fuori, lei era schermata. Proprio perché aveva sofferto così, nessuno strazio più la toccava. «Cosa vi ha reso più semplice alzarvi la mattina e andare a letto la sera dopo un grande lutto? Cosa vi permette di stare bene quando vi sentite afflitti?» La puntata era stata tuttavia molto meno cupa del previsto. Una donna di Aomori aveva raccontato che quando era triste lei cucinava: preparava torte dolci e salate, macaron, confetture, piccole pietanze come crocchette o pesce alla griglia in zucchero e salsa di soia, verdure bollite da infilare nel bentō; aveva persino comprato un freezer a parte per poter congelare quando le prendeva la voglia. Per Hina-matsuri, la festa delle bambine che cadeva ogni 3 di marzo, nel giorno in cui un tempo celebrava la figlia, si premurava di sbrinarlo con precisione. Era certa che guardando l’esposizione delle bambole nel soggiorno, le scalinate con i vari pupazzi che simboleggiavano la famiglia imperiale, avrebbe sentito il bisogno impellente di pelare, tagliare e sbollentare. Cucinare la faceva sentire bene, disse, la aiutava a rimettere le mani sul mondo. Una giovane impiegata di Aichi telefonò invece per dire che lei andava nei caffè ad accarezzare cani, gatti e furetti, sì, soprattutto furetti. Bastava le strusciassero i piccoli musi sulle mani e a lei tornava la gioia d’essere viva. Un anziano, sussurrando perché la voce non raggiungesse in camera da letto la moglie, confessò che giocava al pachinko; un salaryman, che aveva vissuto la separazione dalla fidanzata come un lutto, aveva preso a bere tazze di cioccolata fondente e a sgranocchiare sembei. Tutti sorrisero quando una casalinga di Tōkyō, una donna di circa cinquant’anni che aveva perso la migliore amica in un incidente, raccontò che aveva iniziato a studiare francese e che quel solo modulare la voce diversamente, quella erre di gola e quell’accentazione complessa, le davano l’illusione d’essere un’altra. «Non imparerò mai la lingua, sono proprio negata, ma sapeste come mi fa sentire bene dire bonjuuurrrrrrr.» L’ultima telefonata venne invece da Iwate, da uno dei luoghi del disastro del 2011. La curatrice del programma lanciò un’occhiata eloquente al tecnico del suono, il quale osservò un lungo momento la speaker per poi abbassare lo sguardo sul piano di regia, dove lo lasciò posato fino alla fine della chiamata. Come Yui, l’ascoltatore aveva perso la moglie nello tsunami, la casa divelta dall’acqua, il corpo trascinato tra le macerie: catalogato tra i yukue fumei “traccia ignota”, i dispersi. Ora abitava nella casa del figlio, nell’entroterra, dove il mare era solo un’idea. «E insomma» aveva esordito la voce che aspirava a stretti intervalli una sigaretta «c’è questa cabina telefonica in mezzo a un giardino, su una collina isolata dal resto. Il telefono non è collegato ma le voci le porta via il vento. Dico Pronto Yōko, come stai? e mi pare di tornare ad essere quello di una volta, mia moglie che mi ascoltava dalla cucina, sempre indaffarata sulla colazione o sulla cena, io che brontolavo perché il caffè mi bruciava la lingua.» «Ieri sera leggevo a mio nipote la storia di Peter Pan, il ragazzino volante che perde la sua ombra e la bambina che gliela ricuce sotto la suola, ecco, credo che siamo così anche noi che andiamo su quella collina: cerchiamo di riavere indietro la nostra ombra.» In redazione erano tutti ammutoliti, come se un oggetto estraneo ed enorme fosse improvvisamente precipitato tra loro. Anche Yui, di solito abilissima nel tagliare interventi troppo lunghi con poche, calibrate parole, non fiatò. Solo quando l’uomo tossì e la regia fece sfumare la voce, Yui parve ridestarsi dal sogno. Introdusse precipitosa il brano musicale, si sorprese del titolo, puramente casuale: Max Richter, Mrs. Dalloway: In the Garden. Arrivarono molti altri messaggi quella notte, e continuarono a giungere anche quando Yui era già sul penultimo treno per Shibuya e sull’ultimo per Kichijōji. Chiuse gli occhi, anche se il sonno non arrivava. Tornò e ritornò più volte alle parole dell’ascoltatore, come ripercorrendo in su e in giù la medesima strada e facendo via via attenzione a nuovi dettagli. Un cartello stradale, un’insegna, un’abitazione. Si addormentò solo quando fu certa di aver memorizzato il percorso. Il giorno dopo, per la prima volta da quando sua madre e sua figlia erano morte, Yui chiese due giorni di ferie. Riaccese il motore dell’auto, mise benzina, e con il navigatore satellitare a inanellare una serie compressa di imperativi, si diresse verso il giardino di Suzuki-san. Se non la felicità, perlomeno il sollievo, stavano per diventare una cosa. 2 Scaletta musicale di quella notte durante il programma radiofonico di Yui Fakear, Jonnhae Pt.2 Hans Zimmer, Time Plaid, Melifer Agnes Obel, Stone Sakamoto Kyū, Ue wo mite arukō The Cinematic Orchestra, Arrival of the birds & Transformation Max Richter, Mrs. Dalloway: In the Garden Vance Joy, Call if you need me 3 Mentre trafficava con il navigatore satellitare, Yui si sforzò di non vomitare. Per i primi dieci minuti la vista del mare le fece quell’effetto, glielo faceva ogni volta. Come se solo a guardarlo, quello le entrasse nella bocca; che anzi qualcuno, con un imbuto, glielo facesse ingoiare a forza. Metteva allora di fretta tra le labbra qualcosa, un quadratino di cioccolato, una caramella. In pochi minuti il cuore si abituava e si placavano anche gli spasmi. Nel mese subito successivo allo tsunami, era rimasta sfollata su un telo di due metri per tre, nella palestra di una scuola elementare, insieme ad altre centoventi persone. Eppure la solitudine che aveva sentito in quel posto non l’avrebbe sperimentata mai più. Nonostante una grande nevicata, inaudita a marzo, ogni volta che poteva usciva dall’edificio; si infilava in una crepa del muro che recintava il cortile della scuola, abbracciava un albero che le pareva aggrappato per bene alla terra, e da lì contemplava l’oceano tornato al suo posto, il cratere di macerie che si era lasciato dietro. Aveva scrutato l’acqua con concentrazione, non aveva guardato altro per settimane. Lì dentro, ne era convinta, c’era la risposta. Ogni mattina e ogni sera si recava al Centro Informazioni con la stessa domanda, due nomi, le treccine, i capelli grigi di media lunghezza, il colore di una gonna, il neo sulla pancia. Di ritorno passava veloce nei minuscoli bagni della scuola, frequentati di norma da bambini tra i sei e gli undici anni. Percorreva i corridoi tappezzati di disegni e lavoretti di carta. Tornava nel suo quadrato di vita, ammutolita da tutta quella assurdità. Alcuni, tra i teli stesi a terra sul pavimento di linoleum, parlavano fitto. Dovevano farne parola per essere certi fosse successo davvero. Altri invece non dicevano nulla, come terrorizzati a leggere la pagina successiva, dove sapevano che la tragedia sarebbe avvenuta: si convincevano che se quella pagina non fosse stata voltata, ciò che naturalmente seguiva non sarebbe accaduto. Altri ancora, che sapevano tutto, non avevano più niente da dire. La maggior parte aspettava, e Yui era una di loro. A seconda delle notizie che si ricevevano al Centro Informazioni, si veniva a far parte di un gruppo o di un altro. Talvolta poi si partiva alla volta di un altro rifugio dove c’erano ad attenderli quelli che loro stessi avevano atteso. C’erano centinaia di storie strabilianti da raccontare. Tutto, a recuperarlo, appariva ora come una coincidenza («se non fossi stata a letto malata», «se quel giorno avessi svoltato a destra anziché a sinistra con l’auto», «se non fossi sceso dall’auto», «se non fossimo tornati a casa per pranzo»). Tutti avevano udito la voce della giovane impiegata che dall’altoparlante del Comune, a cento metri dal mare, non aveva smesso un momento di trasmettere l’avvertimento dello tsunami in arrivo, della necessità di correre sulle montagne, nei piani più alti di edifici di cemento armato. Tutti sapevano che neppure lei si era salvata. Le immagini dei cellulari, che la gente ora faceva anche ore di fila per ricaricare, replicavano lo spettacolo insensato di gente aggrappata ai tetti, di macchine travolte dal mare, di case che dopo una strenue resistenza seguivano le persone come lo sciacquo in un lavandino. E poi il fuoco, che nessuno avrebbe mai immaginato più forte dell’acqua, che da piccoli ti insegnano che forbice vince su carta, come carta su sasso; che l’acqua vince sempre sul fuoco, perché lo spegne e sei salvo. Nessuno, in quella rassicurazione infantile ricordava che il tempo decide su tutto e che il fumo riempie i polmoni come una cosa. Che in uno tsunami si muore anche così, senza bisogno di toccare l’acqua. Dall’altura che cingeva la cittadina e su cui, appena concluse le violentissime scosse, si era rifugiata quel giorno, Yui aveva visto l’oceano avanzare. Le era parso lentissimo ma convincente, quasi che non ci fosse altra cosa da fare. Cos’altro mai avrebbe potuto fare un mare se non avanzare? Era distante da casa, e la madre per messaggio era stata talmente rassicurante sulla vicinanza sua e della figlia al rifugio di zona, che aveva seguito la gente, aveva sostenuto un’anziana che camminava a fatica, si era resa utile come poteva, convinta com’era di essere in fondo una sopravvissuta. Per un attimo si era sentita persino in colpa della propria fortuna. Arrivati sullo spiazzo della montagna, si erano tutti affacciati, come a teatro da una balconata. Tenevano in mano i cellulari, animati da una fiducia spropositata nella tecnologia. Parevano tornati tutti bambini, negli anni in cui non esiste confine tra l’eccitazione e la paura. E tuttavia quando il mare attaccò la terra, e non si fermò finché non raggiunse i piedi della montagna, il silenzio fu l’unica cosa. Quella scena fu per Yui talmente surreale, che a lungo non si sentì sicura a cosa avesse effettivamente assistito. Lo tsunami raggiunse un’altezza di molto superiore alla stima prevista, così che alcuni rifugi divennero una formula guasta, una parola sbagliata, come una definizione imprecisa che crea una solida corrispondenza tra due cose che invece non si somigliano affatto. Così era successo anche a sua figlia e a sua madre, che nel rifugio avevano trovato la morte. Per un mese aveva aspettato sul telo di due metri per tre, senza sapere più bene a un certo punto cosa stesse aspettando. I pochi oggetti che aveva appresso al momento del terremoto le rimasero attorno come una ghirlanda. Si aggiunsero bottigliette d’acqua, asciugamani, coppette di rāmen liofilizzato, onigiri, barrette energetiche, assorbenti igienici, energy drink. Circoscritta da cose sempre più vecchie, attendeva che quella cosa finisse. Poi finalmente i corpi vennero ritrovati e Yui smise di guardare il mare.
Imai Messina, Laura. Quel che affidiamo al vento (Italian Edition) (pp.20-27). EDIZIONI PIEMME. Edizione del Kindle.
Autrice: Laura Imai Messina
” Laura Imai Messina è nata a Roma. A 23 anni si è trasferita a Tokyo dove ha conseguito un PhD presso la Tokyo University of Foreign Studies. Insegna in alcune delle più prestigiose università della capitale. Ha esordito con successo nel 2014 con Tokyo Orizzontale (Piemme). Nel 2018, sempre per Piemme, è uscito Non oso dire la gioia, e per Vallardi il bestseller Wa. La via giapponese all’armonia.
Il suo stile raffinato e lo sguardo privilegiato sul Sol Levante ne fanno una voce inconfondibile del panorama letterario italiano. www.lauraimaimessina.com
Interessante l’ intervista all’autrice Laura Imai Messina
https://www.youtube.com/watch?v=nO0izqIIldU

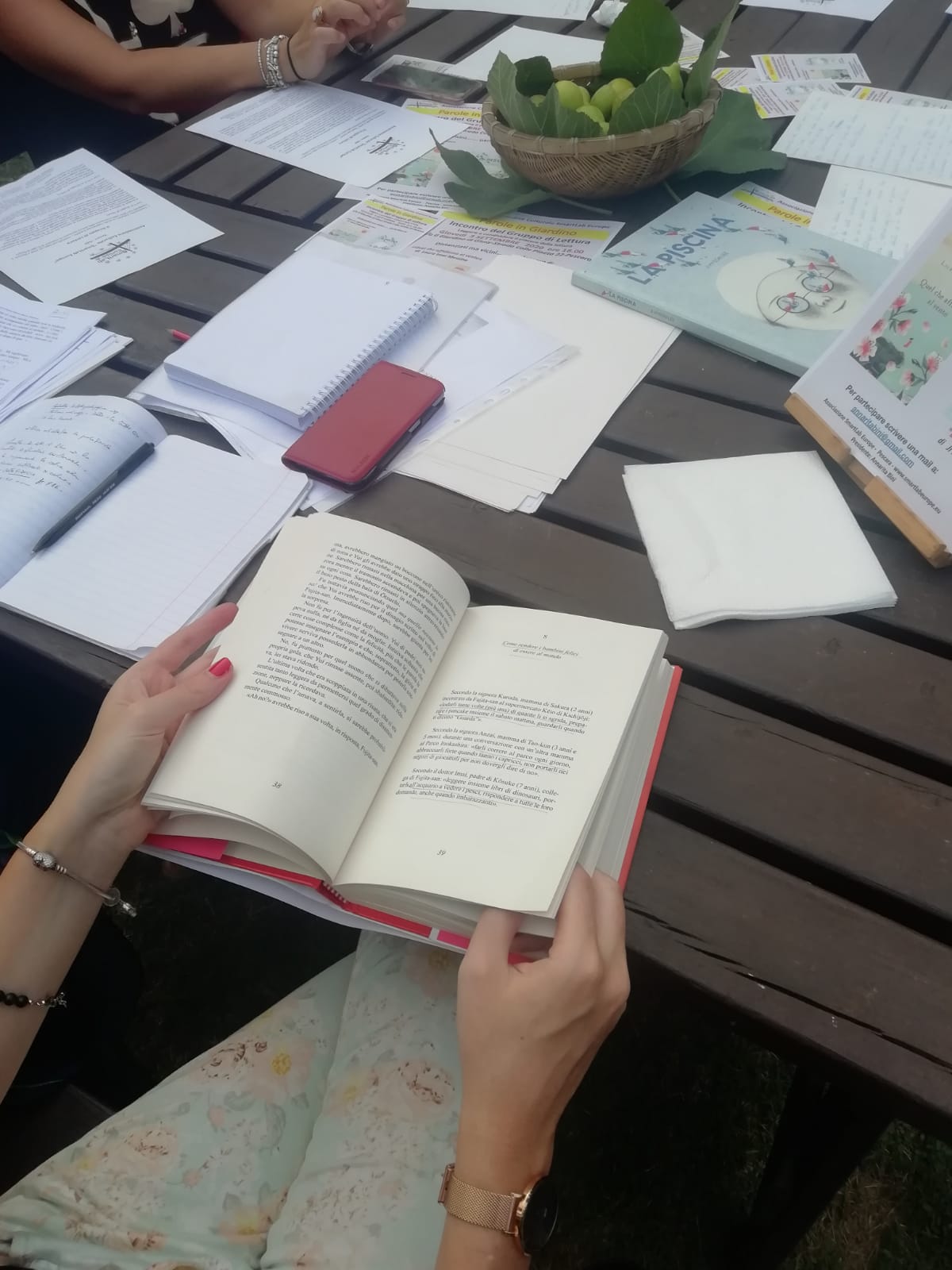















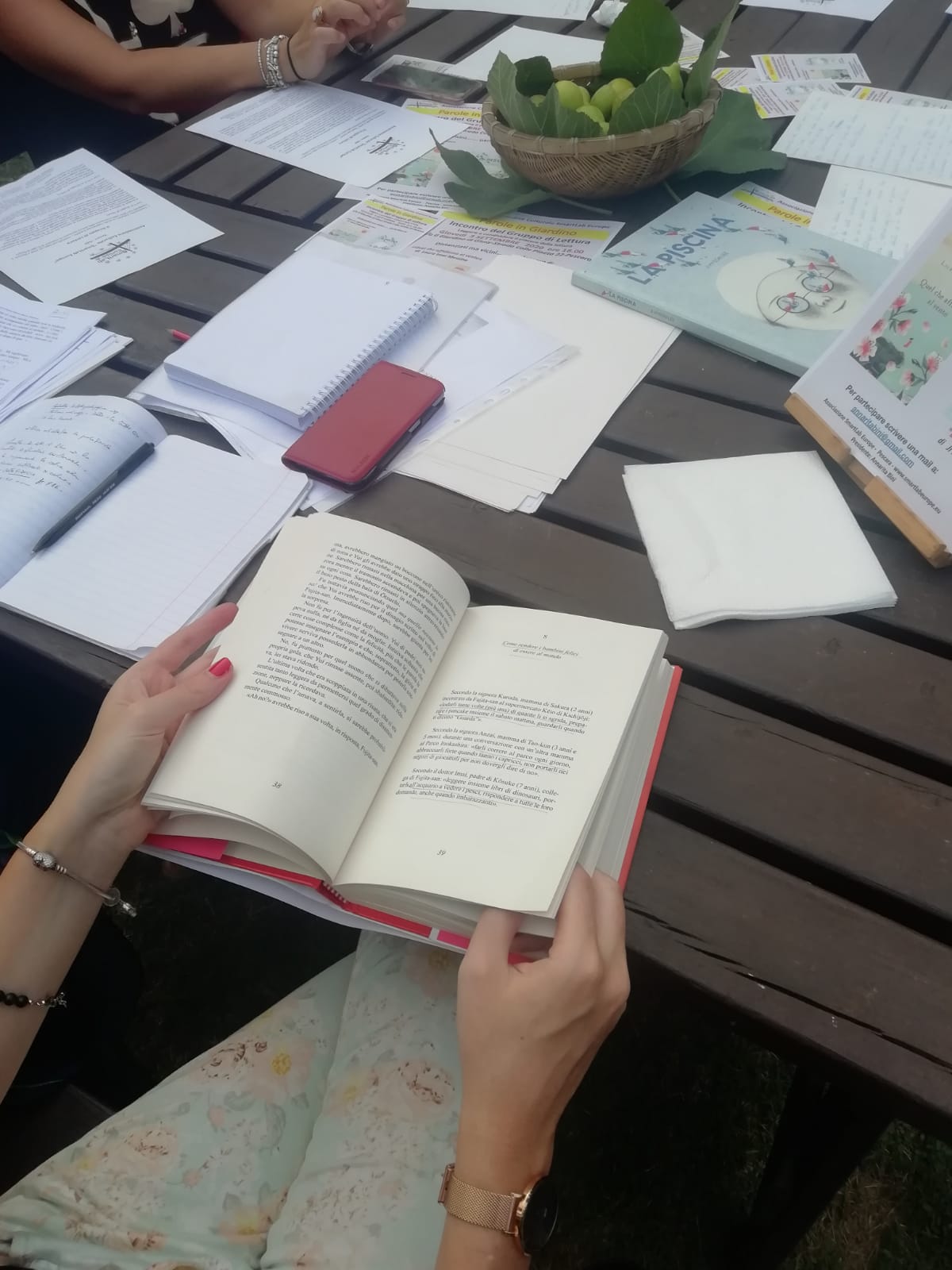

 Incipit
Incipit